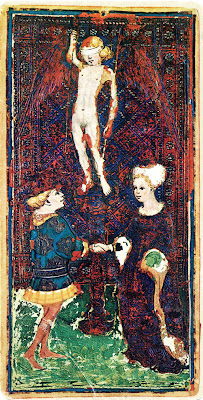Nel 324 dopo Cristo l’imperatore romano Costantino decise di fondare una “Nova Roma” – ora Istanbul - sul sito dell’antica città di Bisanzio, in posizione strategica sullo stretto dei Dardanelli. Con questo gesto rivoluzionario, Costantino sanciva di fatto la separazione tra Impero romano d’Occidente e Impero romano d’Oriente, che sarebbe stata definitivamente ratificata dopo la morte di Teodosio I, nel 395. Costantino – per ragioni politiche molto più che morali – aveva stabilito che i cristiani godessero di libertà di culto. Con l’editto di Milano del 313, aveva definitivamente posto fine alle persecuzioni religiose e permesso la costruzione di luoghi pubblici dove celebrare le cerimonie; le prime, ampie basiliche, si ornarono con mosaici che rappresentavano scene della vita di Cristo, dando di fatto il via all’arte religiosa dell’Occidente e del medio Oriente.Costantino fu anche fautore e responsabile del Concilio ecumenico di Nicea, in cui si combatteva pubblicamente l’eresia, si proclamava il Credo e si affermava definitivamente il primato del Cristianesimo sulle religioni politeiste; in seguito, con l’editto di Tessalonica del 380, Teodosio il grande stabilì che il paganesimo era fuori legge e perseguitabile. Questi eventi storici furono determinanti per l’affermazione del nuovo costume dell’Alto Medioevo.
Verso la fine dell’Impero romano, gli abiti maschili e femminili erano andati incontro a una trasformazione radicale; le conquiste e la conoscenza di usanze totalmente diverse da quelle latine, avevano portato a una ridefinizione del costume. Erano state introdotte le maniche, di origine orientale, e le brache, tipiche dell’Europa del nord, mentre si andava verso una decadenza definitiva della toga, il principale indumento maschile romano, sostituita da mantelli assai più comodi come il Pallium e la Clamide. Anche la donna, uniformandosi ai nuovi canoni estetici, appariva slanciata e sottile, con vesti accollate che coprivano il busto e un mantello leggero che ne proteggeva la pudicizia. Non estranei a questo fenomeno erano i discorsi dei primi apologeti e dei padri della chiesa. Tertulliano in particolare, nel “De cultu foeminarum”, apriva una diatriba sulla vanità femminile, nella convinzione che “la donna è la porta del Diavolo”. San Girolamo ricorda i capelli posticci della vergine Demetriade, mentre Sant’Ambrogio si scagliava contro le pietre preziose che orlavano le vesti , affermando che “sarebbe meglio levigare la durezza del cuore”. Né erano risparmiati gli uomini: a questo proposito una curiosa diatriba su barba e capelli vedeva schierati due partiti opposti. Il primo, rifacendosi alla Bibbia, affermava che non bisognava distruggere i peli che Dio aveva creato; il secondo invitava a radersi per penitenza. Un esempio di abbigliamento del periodo è il famoso “Dittico di Stilicone” in cui il console e generale compare con la moglie Serena in atteggiamento rigido e frontale, indossando gli abiti di moda all’epoca.
La caduta dell’Impero romano nel 476 dopo Cristo, sancì definitivamente l’ascesa dell’Impero d’oriente. Nel 527 tuttavia, l’imperatore Giustiniano I cercò concretamente di riconquistare le regioni occidentali. Ne conseguì la creazione dell’Esarcato d’Italia, che aveva sede a Ravenna e che fu in seguito travolto dalle invasioni longobarde, lasciando alcune colonie in Emilia Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
 Bisanzio era considerata la più bella capitale del mondo conosciuto. Ereditate dall’impero romano lo splendore e le consuetudini, la città conobbe il suo acme sotto Giustiniano (462 – 565) e la moglie Teodora. L’imperatore, poi chiamato Basileus, era divinizzato e considerato il rappresentante di Dio in terra. Era rappresentato frontalmente e con l’aureola, in aspetto rigido, ieratico e disumano come si conveniva a una divinità. I suoi abiti in seta splendevano di ricami aurei. La luce, concetto metafisico alla base dell’arte bizantina, doveva emanare dalla sua persona e dalla consorte. A tal scopo erano fondamentali i tessuti serici coi loro riflessi e bagliori. La seta era stata importata fortunosamente dall’oriente: due monaci avevano infatti introdotto il bozzolo del baco nel cavo del loro bastone, e Giustiniano aveva dato il via ad un importante laboratorio manifatturiero annesso al suo palazzo e severamente protetto contro qualsiasi tentativo di spionaggio.
Bisanzio era considerata la più bella capitale del mondo conosciuto. Ereditate dall’impero romano lo splendore e le consuetudini, la città conobbe il suo acme sotto Giustiniano (462 – 565) e la moglie Teodora. L’imperatore, poi chiamato Basileus, era divinizzato e considerato il rappresentante di Dio in terra. Era rappresentato frontalmente e con l’aureola, in aspetto rigido, ieratico e disumano come si conveniva a una divinità. I suoi abiti in seta splendevano di ricami aurei. La luce, concetto metafisico alla base dell’arte bizantina, doveva emanare dalla sua persona e dalla consorte. A tal scopo erano fondamentali i tessuti serici coi loro riflessi e bagliori. La seta era stata importata fortunosamente dall’oriente: due monaci avevano infatti introdotto il bozzolo del baco nel cavo del loro bastone, e Giustiniano aveva dato il via ad un importante laboratorio manifatturiero annesso al suo palazzo e severamente protetto contro qualsiasi tentativo di spionaggio.  Determinante era l’uso del colore. La porpora, che poteva essere indossata solo dall’imperatore – detto Porfirogenito, ossia nato dalla porpora – era un colorante ottenuto da un mollusco gasteropode, che secerneva un liquido vischioso di colore violaceo, ma che poteva digradare dall’azzurro al rosso. La quantità di prodotto era minima e ci volevano migliaia di molluschi per tingere una veste: per questo motivo era rarissimo e molto costoso, e quindi adatto agli abiti di una divinità in terra. Avvolti nei loro tessuti preziosi, nel palazzo ricco di marmi e mosaici d’oro e ricoperti di gioielli, Giustiniano e Teodora si presentavano al mondo nell’ineffabile luce del loro sfarzo. Il sovrano doveva rappresentare il “Typus Christi”, il simbolo vivente di Cristo e garante della sua Chiesa. Grazie a lui Bisanzio diventò un punto di riferimento fondamentale per l’abbigliamento.
Determinante era l’uso del colore. La porpora, che poteva essere indossata solo dall’imperatore – detto Porfirogenito, ossia nato dalla porpora – era un colorante ottenuto da un mollusco gasteropode, che secerneva un liquido vischioso di colore violaceo, ma che poteva digradare dall’azzurro al rosso. La quantità di prodotto era minima e ci volevano migliaia di molluschi per tingere una veste: per questo motivo era rarissimo e molto costoso, e quindi adatto agli abiti di una divinità in terra. Avvolti nei loro tessuti preziosi, nel palazzo ricco di marmi e mosaici d’oro e ricoperti di gioielli, Giustiniano e Teodora si presentavano al mondo nell’ineffabile luce del loro sfarzo. Il sovrano doveva rappresentare il “Typus Christi”, il simbolo vivente di Cristo e garante della sua Chiesa. Grazie a lui Bisanzio diventò un punto di riferimento fondamentale per l’abbigliamento.  Ravenna conserva ancora nei suoi mosaici l’immagine dell’imperatore e della sua corte. Nella basilica di San Vitale, sono conservati due importanti mosaici che ritraggono la coppia regale circondata dal loro seguito. Giustiniano, rappresentato mentre offre un pane, indossa una lunga clamide purpurea, una tunica di seta e panno aureo, brache e calzari rosso cupo. Il mantello semicircolare e di origine greca, reca una decorazione romboidale detta “tablion”, che sottolineava la differenza di ceto: mentre l’imperatore l’aveva color porpora e ricamata, i dignitari che l’affiancano esibiscono una maggiore semplicità. Anche la spilla che chiude il mantello è una prerogativa imperiale: i funzionari hanno una allacciatura molto più semplice.
Ravenna conserva ancora nei suoi mosaici l’immagine dell’imperatore e della sua corte. Nella basilica di San Vitale, sono conservati due importanti mosaici che ritraggono la coppia regale circondata dal loro seguito. Giustiniano, rappresentato mentre offre un pane, indossa una lunga clamide purpurea, una tunica di seta e panno aureo, brache e calzari rosso cupo. Il mantello semicircolare e di origine greca, reca una decorazione romboidale detta “tablion”, che sottolineava la differenza di ceto: mentre l’imperatore l’aveva color porpora e ricamata, i dignitari che l’affiancano esibiscono una maggiore semplicità. Anche la spilla che chiude il mantello è una prerogativa imperiale: i funzionari hanno una allacciatura molto più semplice.
A fronte di Giustiniano è raffigurata la moglie Teodora, donna di origini modestissime ma dal carattere di ferro, che dal mondo del circo era riuscita a salire alla dignità imperiale e si era circondata di un’aureola soprannaturale. Divinizzata, assorta nella sua rigida posizione frontale, Teodora reca in mano una coppa che sta per offrire alla Chiesa, simboleggiata da una fontana d’acqua zampillante.
 La basilissa indossa un mantello purpureo, decorato sul bordo con le immagini dei re Magi, e una tunica lunga. La ancelle del seguito portano invece un mantello più corto e chiuso, e un velo arrotolato in testa. I sovrani sono carichi di gioielli: entrambi portano la corona. Quella di Giustiniano è più piccola e a pendenti, mentre Teodora ha un diadema straordinario, decorato di perle e gemme, che fa pendant col maniakon, il collare che ricorda quello dell’aristocrazia egiziana. D’altro canto gli influssi della civiltà del Nilo, conquistata da Alessandro Magno, non potevano non essere presenti in Grecia e in Turchia, grazie anche agli stretti rapporti commerciali.
La basilissa indossa un mantello purpureo, decorato sul bordo con le immagini dei re Magi, e una tunica lunga. La ancelle del seguito portano invece un mantello più corto e chiuso, e un velo arrotolato in testa. I sovrani sono carichi di gioielli: entrambi portano la corona. Quella di Giustiniano è più piccola e a pendenti, mentre Teodora ha un diadema straordinario, decorato di perle e gemme, che fa pendant col maniakon, il collare che ricorda quello dell’aristocrazia egiziana. D’altro canto gli influssi della civiltà del Nilo, conquistata da Alessandro Magno, non potevano non essere presenti in Grecia e in Turchia, grazie anche agli stretti rapporti commerciali.
Un ulteriore esempio del costume bizantino – peraltro molto avaro di descrizioni storiche e letterarie – si può osservare nella basilica di Sant’Apollinare nuovo, sempre a Ravenna. Nella navata centrale, due teorie di Vergini e di Martiri si dirigono verso l’altare recando le loro corone sulle mani velate. Le donne indossano una tunica con la cintura sotto al seno, ripresa da un lato in modo da evidenziare l’orlo apparentemente tagliato obliquo. Gli uomini invece hanno tunica e il Pallium di colore bianco, ornato con una lettera dell’alfabeto greco; questo costume semplice, col mantello che scopre una spalla, si può vedere anche nei mosaici di Galla Placidia.
Alla fine della processione delle vergini, i re Magi offrono doni alla Madonna in trono; il loro costume, formato da brache, tunichetta e mantello, è corredato da scarpe a punta arricciata e berretto frigio. Definito costume palmireno, ossia proveniente dalla città romana di Palmira in Siria, l’abito è un tipico esempio dell’influenza mediorientale in occidente; il berretto frigio, rosso e con la punta rivoltata, diventerà famoso in Europa durante la Rivoluzione francese come simbolo di libertà. La sua forma particolare nasce da una pelle di capretto aperta; migrato nel costume ellenistico, divenne poi uno degli attributi tipici del dio Mitra, il cui culto si estese all’antica Roma. In seguito fu donato dai padroni agli schiavi liberati. Da qui diventò simbolo di indipendenza.
Bibliografia:
Rosita Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, Istituto editoriale italiano, Milano, 1964